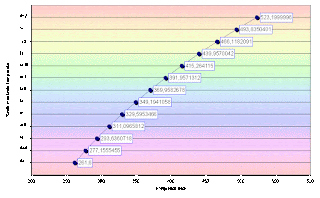Giovedì 28 aprile ho presentato una relazione su musica e numeri per l'
associazione culturale Voltalacarta di Heidelberg.
Il materiale audiovisivo, già utilizzato in parte per la
lezione interattiva per una terza media romana, è stato costruito seguendo questo filo conduttore: “Perché c’è una relazione tra matematica e leggi che regolano l’universo? Durante la presentazione si mostrerà: a quale intuizione dei pitagorici si faccia risalire questa scoperta; come questa intuizione abbia a che fare con i suoni e con la musica; e quali furono le conseguenze in relazione agli sviluppi futuri della scienza e della matematica.“
Come integrazione alle due ore di presentazione ho pensato di scrivere commenti e risposte alle domande ricevute in una forma utile sia a chi ha partecipato alla serata sia a chi non lo ha fatto in quanto il tutto è formulato in modo tale da non richiedere prerequisiti, tranne una cultura matematica di base.
Commenti
Dopo la lettura dell'amica Nadia della scena che descrive la possibile dimostrazione di Ippaso
dell'
irrazionalità della radice di due, ho dimenticato di dire alcune cose.
1.
Quella fu probabilmente la prima volta nella storia in cui veniva usato il metodo della dimostrazione matematica in ambito numerico. Infatti, quel metodo, che è uno dei mattoni più importanti delle fondamenta su cui è costruito l'edificio della matematica, nasce proprio in quel periodo (VI sec. a.C): grazie a
Talete in ambito geometrico, e grazie ai pitagorici in ambito numerico.
2.
Non solo! La scena mostra anche che Ippaso e Pitagora, partendo dall'ipotesi che la radice di due sia una frazione, deducono un risultato assurdo; concludendo così che l'unica spiegazione possibile sia che l'ipotesi fosse sbagliata. E cioè che la radice di due non possa essere una frazione.
Inventano così anche il metodo di dimostrazione per assurdo: uno dei metodi di dimostrazione più usati in tutta la storia successiva della matematica. Tant'è che persino
Andrew Wiles lo usa nel 1994 per la sua dimostrazione dell'
ultimo teorema di Fermat1 di cui ho parlato durante la relazione.
3. Ma non è finita qui! Quella particolare dimostrazione per assurdo di Ippaso usa un metodo noto come
metodo della discesa infinita. Un metodo che sarà usato spesso in seguito.
Insomma,
per riassumere, i pitagorici idearono tre formidabili strumenti matematici il cui grado di importanza e di generalità varia dalla sconfinatezza del primo (la dimostrazione); alla maggiore specificità del secondo (la dimostrazione per assurdo), sottoclasse del primo; fino alla tecnicità del terzo (metodo della discesa infinita), sottoclasse del secondo.
Domande
1. Perché i battimenti, il cui grafico sembra così regolare, producono una sensazione acustica poco piacevole?
Prima di tutto perché
la modulazione in ampiezza dell'onda risultante, seppur periodica e regolare, ha una frequenza così bassa da farci sentire quella fastidiosa vibrazione del suono risultante.
Poi c'è anche il fatto che
le sinusoidi dell'immagine sono semplificazioni mentre l'onda risultante di due suoni reali, arricchita dalla somma dalle onde degli armonici, non sarebbe così bella e regolare. Inoltre, i suoni reali le cui frequenze stanno in rapporti non semplici hanno meno armonici in comune. O, detto in altri termini,
più i numeri al numeratore e al denominatore del rapporto tra le frequenze sono grandi meno armonici in comune avranno i due suoni e quindi più aspra e dissonante risulterà la combinazione dei due suoni.
2. Perché ci fu l’esigenza di passare alla scala temperata? E perché proprio in quel momento (XVII-XVIII sec.)?
Secondo me per tre innovazioni fondamentali affermatesi lentamente soprattutto nell'arco dei 3-4 secoli precedenti. E cioè: l’affermazione della
musica polifonica, della
musica strumentale e, ultima ma più importante, della
musica tonale. Con la musica vocale il problema non sussisteva per l’ovvia capacità della voce di aggiustare l’intonazione. Il problema comincia invece a porsi quando si mettono insieme tutti questi pezzi: la musica polifonica, la musica strumentale e, soprattutto, il cambio di
tonalità (o
modulazione: da do maggiore a fa maggiore, da fa maggiore a fa minore, ecc) introdotto con la musica tonale e che non esisteva nella precedente
musica modale (quella del Gregoriano per intenderci).
Ed è soprattutto il cambio di tonalità il grosso problema. Perché per non far variare le distanze tra i gradi delle scale in due tonalità diverse (come do maggiore e do# maggiore ad esempio)
si sarebbe dovuto riaccordare lo strumento nel passaggio da una tonalità all'altra.
Tutta questa evoluzione storica è spiegata molto bene nel capitolo "Dalla modalità alla tonalità" della
pagina di Wikipedia sulla Musica modale.
Inoltre, quando avevo già quasi terminato la messa a punto del materiale per la mia lezione/relazione ho scoperto questo video:
Incontro con Andrea Frova - Musica e numeri. E anche lì,
al min 25 sec 22, se ne trova una bella spiegazione. Tra l’altro lì Andrea Frova cita anche come
Bach, maniaco dell’intonazione, affrontasse il problema prima che si cominciasse a usare la scala temperata: quando il pezzo cambiava tonalità lui si fermava e riaccordava tutto il clavicembalo.
Al min 33 sec 10 c’è anche un esempio di un pezzo dal clavicembalo ben temperato suonato nei diversi temperamenti. Credo che un orecchio poco sensibile alle intonazioni non riesca a percepire molta differenza.
3. Qual è il ruolo del cervello nella percezione del suono?
La domanda probabilmente mi è stata posta perché
avevo messo parzialmente in dubbio la relatività che molti musicologi attribuiscono alla percezione della consonanza e della dissonanza. Io credo che ci sia una relatività ma solo entro certi limiti. Per corroborare questa ipotesi mi rifaccio anche ad
Andrea Frova, che sostiene con convinzione tale interpretazione. Ad esempio,
al min 11 del suddetto video afferma che
la differenza tra consonanza e dissonanza è percepita in tutte le culture musicali e anche da neonati e animali (alcuni studi hanno mostrato che i macachi preferiscono le consonanze).
Inoltre
al min 41 sec 11 Frova approfondisce il ruolo del cervello nella percezione delle consonanze e delle dissonanze e, intorno al minuto 45, mostra la risposta del cervello dei gatti a vari tipi di consonanze e dissonanze.
Quindi,
è vero che il cervello può anche imparare ad apprezzare le dissonanze, ma, come mostrano diverse prove, è anche vero che un cervello dotato di poche sovrastrutture culturali apprezza le consonanze ma non molto le dissonanze.
Questo fatto è sintetizzato molto bene da una frase del compositore
György Ligeti:
"La storia della musica non è altro che un percorso di adattamento dell'uomo alle dissonanze."
1 Si sapeva che se fosse stato falso il teorema di Fermat allora si sarebbe potuta costruire una funzione che avrebbe contraddetto la congettura di Tanyama-Shimura. E così, dimostrando la congettura di Tanyama-Shimura (un risultato molto più importante del teorema di Fermat), Wiles dimostrò anche il teorema di Fermat. Perché la sua falsità avrebbe prodotto una contraddizione.